Devi aver fatto il pieno d’amore per aver dato vita ad un disco così. E devi esser disposto a donarlo agli altri, tutto questo amore.
“Phantom Actors nasce dopo un periodo nel quale ho ascoltato molta musica ambient di Detroit, artisti come Tony Drake, The Detroit Escalator Co. e John Beltran. Avevo bisogno di produrre qualcosa che avesse a che fare con lo spazio e con il silenzio dopo aver lavorato con strutture molto più dense e stratificate per il progetto Land Of Light.”
Jonny Nash è parte attiva di alcuni dei progetti più interessanti degli ultimi anni, a voler esser pignoli potremmo partire da quel favoloso e sottovalutato Ep composto insieme all’amico Tako Reyenga ed intitolato Journey To The Centre Of The Sun a nome Sombrero Galaxy. Era il 2010. Ancora, l’intrigante album Land Of Light insieme a Kyle Martin, o il recente album targato Gaussian Curve in trio con Gigi Masin e Young Marco. Una direzione che punta verso una musicalità marcatamente melodica, e non potrebbe esser altrimenti, visto che Nash è un polistrumentista in grado di cogliere l’essenza da ogni strumento utilizzato.
Ci raccontava dello spazio e del silenzio; questo Phantom Actor (secondo lavoro pubblicato a suo nome dopo l’introvabile esordio dello scorso anno sulla giapponese Snaker) è concepito proprio per sfruttare dei tempi dilatati, distese nelle quali amplificare degli accordi semplici ma rilasciati attraverso vibrazioni capaci di penetrare negli strati più profondi dell’anima.
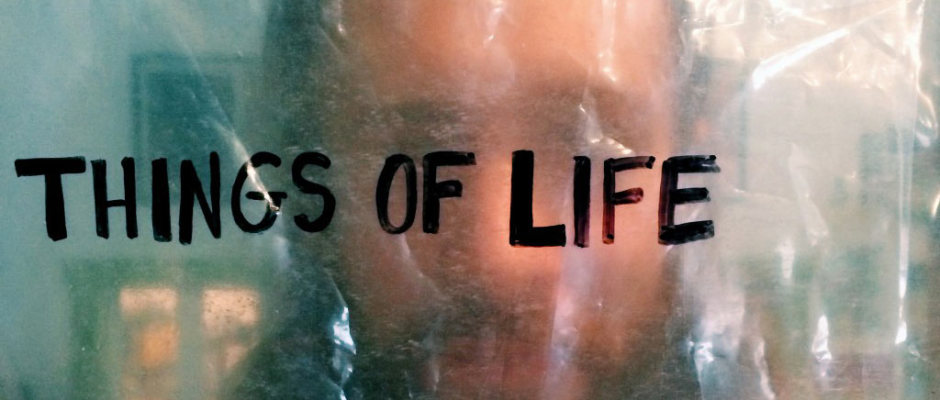
Basterebbe il brano d’apertura, Shallow Space. Sequenze di tre note di pianoforte intervallate da un pad delicato, al secondo giro sei già uno straccio, emergono tutte le emozioni insieme al calore corporeo, ti senti bruciare mentre in quei quattro minuti accade sempre la stessa cosa, si manifesta l’amore.
E’ il suono della chitarra a saturare l’aria di Vision Partially Obscured, qualche percussione lontana, ancora un pianoforte, siamo in uno di quei tramonti balearici che non devono spiegar niente a nessuno. Parla il momento, un’istantanea che profuma di eterno, e si sazia di quel che trova in quell’esatto momento.
I battiti risuonano in lontananza, sono percussioni che anticipano la notte. Dei tappeti atmosferici che ispessiscono il buio, quel pianoforte che sembra distillare gocce d’acido proprio all’ingresso della notte. Year Of The Wooden Horse reinterpreta con imbarazzante fedeltà quel che tutti sappiamo solo immaginare di una città come Detroit.
Il brano più lungo, quello che satura tutto lo spazio e forse anche il più complesso. Dà il titolo al disco ed in qualche maniera è la summa di tutte le parti chiamate a giocare. C’è poco di tutto, in tempi che lasciando intendere lunghi respiri ma colmi di suono e di un’inafferrabile groove cosmico che è in tutto e per tutto magia.
Il finale è uno di quei luoghi dove spogliarsi degli strati superficiali e trovare la pace. Un incanto di pianoforte, elettronica d’ambiente ed il soave suono di una tromba.
Potrebbe passare inosservato a molti, non è difficile, l’attenzione che si dedica a composizioni così semplici e di getto è sempre meno, ed infatti questo è proprio uno di quegli esempi di dischi per pochi, sentitevi anche parte di un élite ma non perdete mai il contatto con il vero messaggio che questa musica vuol dare: tornate ad innamorarvi della semplicità.



